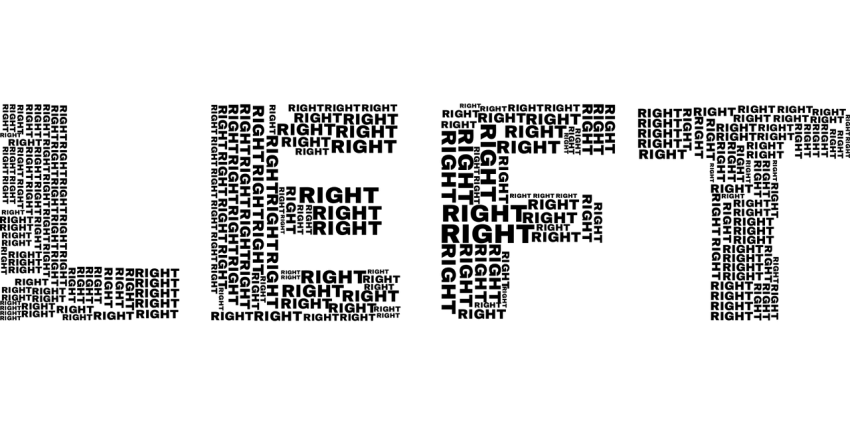
Tratto da https://dizionariostoricocritico.wordpress.com/2018/10/31/sinistra-ragion-dessere/
“La disorganizzazione e la mancanza di unità ai vertici del governo, l’esercito al collasso, il malcontento, l’insicurezza e la paura delle classi abbienti, il profondo risentimento diffuso tra le masse popolari, il proletariato sempre più numeroso, gli eventi forgiati nel fuoco: tutto questo ci dà il diritto di affermare che siamo testimoni dell’inizio della seconda rivoluzione russa. La nostra speranza è che molti di noi vi prenderanno parte”. Questo il passaggio conclusivo di un articolo di Lev Trockij apparso il 12 marzo 1917 sulla rivista degli esuli socialisti russi a New York, Novyi Mir (diretta, tra gli altri, da Nikolaj Bucharin). La Rivoluzione d’Ottobre si approssimava; di lì a qualche mese il bolscevismo e il marxismo-leninismo avrebbero trionfato. Rivoluzione Perfino l’elettore di sinistra sufficientemente colto da ricordare tali avvenimenti e da averne compreso cause e conseguenze di breve e di lungo periodo non potrà, rileggendoli a distanza ormai di un secolo, non percepire un certo distacco. Un primo motivo è riconducibile alle drammatiche ricadute della Rivoluzione: dopo il 1917, quando ancora le Tesi d’aprile di Lenin potevano essere messe in discussione e nel Partito bolscevico era ammesso un sia pur minimo dissenso, si assistette alla progressiva, inesorabile identificazione dell’opposizione interna col tradimento. Nonostante i moniti in favore della libertà rivoluzionaria di Rosa Luxemburg, la concatenazione di eventi che partì dai fatti di Kronštadt del 1921 condusse, con la morte di Lenin nel 1924, con le dimissioni di Trockij dalle cariche di commissario alla Guerra e di presidente del Consiglio militare rivoluzionario nel 1925 e, infine, con l’espulsione dal Partito nel novembre del 1927 di quest’ultimo insieme a Zinov’ev e a Kamenev, all’instaurazione del totalitarismo staliniano. Di qui il Gulag, le purghe del 1937-1938, i piani quinquennali e così via. Per dirla con Paolo Flores d’Arcais, “la vicenda del potere bolscevico, almeno da Kronštadt in poi, insegna solo cosa una rivoluzione non può e non deve essere”.
Ma esiste almeno un’altra ragione fondamentale del distacco sopra accennato, ed è una ragione intimamente connessa al recente passato. Nonostante la stagione del riformismo di Gorbačëv all’insegna della glasnost e della perestrojka, il muro di Berlino crollò nel 1989 e l’URSS si sciolse nel 1991. La Russia e, più in generale, l’Europa orientale, passavano a un sistema di libero mercato, mentre la fallimentare esperienza del patto di Varsavia (1955) giungeva al termine. Nell’Europa occidentale comunista e socialista calava invece un sinistro imbarazzo: come fingere che nulla fosse accaduto? Assillato dalla scomoda domanda, il Partito Comunista Italiano di Achille Occhetto, a partire dalla cosiddetta svolta della Bolognina del 12 novembre 1989, si avviò tra dibattiti e dissensi all’inevitabile scioglimento, da cui nacquero, da un lato, il Partito Democratico della Sinistra (dal 1998 Democratici di Sinistra) e, dall’altro, Rifondazione comunista.
Questa sorta di “diecismo” imposto dalle circostanze ebbe una portata storica non inferiore alla fondazione del Partito Comunista a Livorno nel 1921 o alla scissione di Palazzo Barberini del 1947, poiché, come appunto queste due svolte cruciali, inaugurò una nuova epoca per la multiforme galassia delle sinistre italiane. Da questo momento, infatti, il modello statunitense e il capitalismo vittorioso, ormai privi di rivali temibili, espugnarono a poco a poco tutte le roccaforti dei nemici di un tempo, o persuadendoli della propria presunta rettitudine (si vedano, soprattutto, i fautori italiani della cosiddetta Third Way e le proposte di una grossa fetta dei dirigenti dell’attuale Partito Democratico), o declassandoli a movimenti minoritari destinati all’irrilevanza (è il caso di Rifondazione comunista). E la stessa transizione, pur con numerose differenze nelle modalità e nei tempi, è avvenuta nella gran parte della restante Europa occidentale: dall’opposizione aperta, o quantomeno dalla visione critica, del sistema capitalistico globale e dei suoi eccessi all’accettazione incondizionata e fatalista dei principi del neoliberismo. “Le differenze tra destra e sinistra”, sentenziava Tony Blair nel 2007, “non esistono più. La differenza sta nell’apertura o nella chiusura alla globalizzazione”. E poi proseguiva: “ci sarà una modernizzazione permanente e sarà premiato solo chi sarà in grado di adattarsi a questo mutamento costante”. Questa specie di darwinismo socio-economico, di legge del più forte proveniva da un laburista, un paradosso che la crisi finanziaria del 2007-2008 ha crudelmente messo a nudo di fronte all’opinione pubblica e, in particolare, ai ceti più bassi della popolazione, per anni incoraggiati dai loro presunti difensori a godere di vantaggi e di opportunità che, in realtà, mai il sistema ha loro riservato. Proprio le recenti crisi e rimessa in discussione del capitalismo hanno aperto in Italia un acceso (ma il più delle volte sterile) dibattito su cosa sia “di sinistra” e cosa no, sul se sia meglio accettare l’assetto socio-economico esistente con le sue disparità o tentare di smussarne gli angoli in qualche modo. In altri termini, la necessità storica della dittatura del proletariato profetizzata da Marx, e attuata dai bolscevichi nel 1917, si è ridotta a un vuoto conflitto di etichette che cela il profondo, deprimente dubbio esistenziale tipico delle sinistre del nostro tempo. Prima ancora di interrogarsi su volti, partiti e programmi, occorre allora chiedersi: il dubbio è fondato?
È il Novecento a negarlo. Cerchiamo di capire perché. Dopo la Grande Guerra, il fascismo e il comunismo, distanti quasi su tutto, avevano in comune quantomeno il nemico: la cultura liberale, il capitalismo. Ma la Seconda Guerra Mondiale e l’inarrestabile avanzata del Terzo Reich costrinsero l’universo comunista ad accettare un’opportunistica alleanza con gli Stati Uniti e con le democrazie liberali europee. Nonostante la vittoria nel conflitto e il riassetto del mondo durante le conferenze di Teheran, di Mosca, di Bretton Woods, di Yalta, di Potsdam, di Parigi, l’illusione di un nuovo e pacifico ordine globale si infranse subito contro la cortina di ferro della Guerra Fredda.
Eppure l’Occidente non dimenticò i rischi sociali e politici insiti in un liberismo fuori controllo e, perciò, tentò di riformarsi guardando proprio ai modelli socialisti e comunisti, oltre che alle teorie di Keynes: ne derivò, tra gli anni ’50 e ’60, l’adozione di politiche di welfare, di contrasto alle disuguaglianze, di solidarietà, di interventismo statale. Ma la crisi petrolifera del 1973 e la stagflazione conferirono nuova attrattiva ai paradigmi del laissez-faire. Dopo l’esordio nel Cile di Pinochet, l’ondata neoliberista colpì soprattutto gli Stati Uniti, con le presidenze di Ronald Reagan (1980-1988), e il Regno Unito, con le riforme della Thatcher (1979-1990). Tra massicci tagli fiscali alle imprese, deregulation del mercato del lavoro e drastiche riduzioni della spesa sociale, le disparità tra individui e tra classi crebbero a dismisura (lo attesta, a titolo di esempio, il costante aumento del coefficiente di Gini negli U.S.A. dal 1980 ad oggi).
Il guaio fu che, nel frattempo, l’URSS, come sopra ricordato, giungeva al tracollo definitivo. Fu così che, dopo il 1989, non rimase sulla scena altro che il capitalismo, inteso qui come potere non soltanto economico e politico, ma anche sociale e culturale. Un potere che genera un sapere, direbbe Michel Foucault. Ora, constatare il suo trionfo non implica affatto sminuirne gli innumerevoli difetti intrinseci, che anzi devono essere chiari: si pensi, in particolare, alla ciclicità delle sue crisi (già intuita da Kondratiev), alla sua inevitabile produzione di disuguaglianze, qualunque sia la scala geografica considerata (illuminanti, in proposito, gli studi sullo sviluppo polarizzato regionale di Myrdal e di Perroux), alla sua tendenza a comprimere progressivamente i diritti delle classi lavoratrici (Marx docet) e, per riprendere il sociologo ed economista Immanuel Wallerstein, a costruire un sistema-mondo piramidale e a suddividerlo in tre componenti distinte ma gerarchicamente connesse, centro, semiperiferia e periferia. Un discorso a parte, poi, lo meriterebbero le ombre e gli eccessi della società dei consumi di massa, esito più appariscente del tardo capitalismo, contro cui la Scuola di Francoforte di Theodor Adorno e, in Italia, Pier Paolo Pasolini mossero già tra gli anni ’40 e ‘60 critiche pungenti e di persistente attualità.
L’egemonia culturale capitalistica genera indifferenza, “la palla di piombo per il novatore” secondo Gramsci: il contagio va fermato. Ed è alla sinistre che spetta l’arduo compito. Il che significa, a mio avviso, analizzare gli squilibri del capitalismo, combatterli, arginarli, eliminarli ove possibile. E, dunque, promuovere in primo luogo istanze di uguaglianza, di tutela del lavoro, di giustizia sociale, attraverso strumenti adeguati al presente. L’interrogativo posto da Hobsbawm al nostro tempo dovrebbe assillare i socialdemocratici, giorno e notte: la rimozione dei difetti intrinseci del capitalismo “quali mutamenti del sistema esigerebbe”? Una sinistra illuminista, per definirsi tale, non può adagiarsi acriticamente sulla realtà alla maniera di Blair e dei suoi eredi, ma, al contrario, deve tentare di trasformarla, con l’impegno e l’audacia di un Voltaire, di un Rousseau, di un Diderot, di un d’Alembert, di un Montesquieu. In definitiva, se rinunciasse a questo slancio al contempo distruttivo e creativo, negativo e positivo, la sinistra rinuncerebbe a se stessa, un lusso che, nell’epoca del capitalismo al comando e potenzialmente senza rivali, non può proprio permettersi. Sul punto, l’ottimo Bernie Sanders, un autentico e coraggioso socialdemocratico del XXI secolo, insiste di continuo: “Democratic socialism means that we must reform a political system that is corrupt, that we must create an economy that works for all, not just the very wealthy”.
Tra i valori irrinunciabili della sinistra, vengono poi l’internazionalismo, l’europeismo (cfr. voce Europeismo), il femminismo, l’inclusione dello straniero, la tutela delle minoranze, la lotta a qualunque forma di discriminazione, i diritti delle coppie omosessuali: battaglie tutt’oggi fondamentali e, per molti versi, ancora da vincere. Ma non le approfondirò in questa sede, giacché, attualmente, la tentazione per così dire “americaneggiante” dell’area progressista italiana non parrebbe tanto quella di mettere da parte la questione dei diritti individuali di libertà, ma, al contrario, quella di elevarli a fine ultimo del proprio operato politico, in barba alle cause delle classi disagiate, dei lavoratori, dei deboli. Andrebbe riascoltata la lezione del socialista Pietro Nenni: “Le iniquità sociali sono alte e potenti, ma non è detto che non possano essere abbattute”. La ricerca della nostra ragion d’essere inizia da qui.

