Recensione de Il Viaggio di Arlo
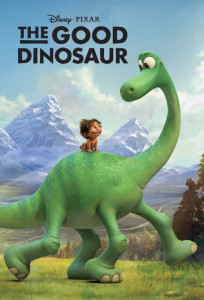 C’era un tempo in cui i Pixies cantavano al mondo “Where is my Mind?”. Quella canzone sarebbe stata ricordata non solo per il testo e la musica, ma soprattutto per essere l’accompagnamento musicale di uno dei finali più affascinanti, d’effetto, prevedibili, introversi e stupefacenti del cinema degli ultimi anni. Si parla ovviamente del Fight Club di Fincher di cui è bene astenersi sempre dal parlarne per non infrangerne la prima regola.
C’era un tempo in cui i Pixies cantavano al mondo “Where is my Mind?”. Quella canzone sarebbe stata ricordata non solo per il testo e la musica, ma soprattutto per essere l’accompagnamento musicale di uno dei finali più affascinanti, d’effetto, prevedibili, introversi e stupefacenti del cinema degli ultimi anni. Si parla ovviamente del Fight Club di Fincher di cui è bene astenersi sempre dal parlarne per non infrangerne la prima regola.
Perché citare un film drammatico ed una canzone rock quando ci si appresta a recensire un’opera realizzata fondamentalmente per un pubblico giovane ed infantile, ancora lontano ed ignaro dei mali e dei problemi del mondo (ed insiti nell’uomo)? Il motivo è semplice e lo si può trovare con facilità una volta terminata la visione dell’ultimo progetto d’animazione della casa di produzione con la prestigiosa lampadina saltellante: arrivati ai titoli di coda, infatti, la prima cosa che lo spettatore avrebbe ben diritto e dovere di chiedersi è “Where is the Pixar?”.
 In effetti la visione de Il Viaggio di Arlo è un po’ come quella che Edward Norton ha alla fine di Fight Club. I palazzi che cadono in questo caso sono le aspettative e le speranze che potevano essere riposte in un progetto venuto alla luce subito dopo quel capolavoro di Inside Out dallo stesso team di sviluppatori.
In effetti la visione de Il Viaggio di Arlo è un po’ come quella che Edward Norton ha alla fine di Fight Club. I palazzi che cadono in questo caso sono le aspettative e le speranze che potevano essere riposte in un progetto venuto alla luce subito dopo quel capolavoro di Inside Out dallo stesso team di sviluppatori.
Arlo, al contrario, non solo è un passo falso pesante, ma, quel che è peggio, distrugge gran parte di quanto visto negli anni passati e frantuma gran parte della poesia e della poetica Disney / Pixar a cui siamo stati abituati e forse, si potrebbe azzardare a sussurrare, viziati.
Cresciuto in una famiglia a ridosso delle montagne, Arlo è il minore dei tre fratelli, ed anche il più gracile. Suo padre e sua madre cercano in continuazione di spronarlo a raggiungere un obbiettivo e portarlo a termine, rendersi utile per il mantenimento della fattoria ed il benessere collettivo, ma il giovane Apatosauro fatica enormemente a dare il proprio contributo, poiché troppo timido e pauroso di quel che lo circonda.
 The Good Dinosaur, come suggerisce il titolo, dovrebbe essere un classico racconto di formazione, ove il protagonista subisce, con il passare del tempo, una trasformazione ed una maturazione psicologica capace di coincidere con il passaggio dall’infanzia all’adolescenza fino all’età adulta. Esattamente come per Il Re Leone, anche Arlo, proprio come Simba, assiste alla prematura morte del padre, entrambi genitori strappati via dall’incontrollabile forza della natura e dalle circostanze sinistre che hanno visto coinvolti i loro figli; tuttavia, laddove il piccolo cucciolo di leone mostrava, fin da subito, un senso di colpa radicato profondamente nella sua persona, tanto da fargli desiderare la morte, quel che il giovane dinosauro prova è rabbia, frustrazione, rancore non verso se stesso, ma nei confronti del piccolo umano Spot, cucciolo d’uomo anch’egli orfano di una famiglia, la cui colpa è pressoché nulla dinnanzi allo svolgersi drammatico degli avvenimenti e ciò che ne è conseguito.
The Good Dinosaur, come suggerisce il titolo, dovrebbe essere un classico racconto di formazione, ove il protagonista subisce, con il passare del tempo, una trasformazione ed una maturazione psicologica capace di coincidere con il passaggio dall’infanzia all’adolescenza fino all’età adulta. Esattamente come per Il Re Leone, anche Arlo, proprio come Simba, assiste alla prematura morte del padre, entrambi genitori strappati via dall’incontrollabile forza della natura e dalle circostanze sinistre che hanno visto coinvolti i loro figli; tuttavia, laddove il piccolo cucciolo di leone mostrava, fin da subito, un senso di colpa radicato profondamente nella sua persona, tanto da fargli desiderare la morte, quel che il giovane dinosauro prova è rabbia, frustrazione, rancore non verso se stesso, ma nei confronti del piccolo umano Spot, cucciolo d’uomo anch’egli orfano di una famiglia, la cui colpa è pressoché nulla dinnanzi allo svolgersi drammatico degli avvenimenti e ciò che ne è conseguito.
Per questo motivo la pellicola di Peter Sohn, oltre ad avere una trama banale e scontata, è particolarmente fastidiosa, poco profonda e non particolarmente educativa o brillante anche sotto il lato comico. Toltole un qualunque valore didascalico, essa rappresenta comunque la pagina più oscura della Pixar, perché se i personaggi a cui ci hanno abituato Lasseter, e compagnia, hanno sempre conquistato lo spettatore per le loro mille sfaccettature, innalzandosi a protagonisti o comprimari a tutto tondo, non manichei o superficiali, quello a cui ora siamo messi davanti è un teatro di comparse che non lasciano il segno, e, quel che è peggio, a non funzionare è proprio il piccolo Arlo, il quale con l’avanzare della storia dimostra semplicemente di essere troppo stupido per arrivare ad articolare pensieri o ragionamenti  interessanti o con cui immedesimarsi, risolvendo continuamente ogni situazione urlando a squarciagola o piangendo, rifacendosela con gli altri, senza mai assumersi un minimo di colpa e responsabilità.
interessanti o con cui immedesimarsi, risolvendo continuamente ogni situazione urlando a squarciagola o piangendo, rifacendosela con gli altri, senza mai assumersi un minimo di colpa e responsabilità.
Chi era alla ricerca di un animale antropomorfo ostico, difficile da digerire e sopportare, avrà ciò che desidera su un piatto d’argento, ed ancor più fastidioso è un finale melenso ove il “Good Dinosaur” trova, finalmente, un’umanità degna di tanti altri suoi “gemelli d’animazione”, a cui, purtroppo, è difficile credere fino in fondo, facendolo diventare, a maggior ragione, una personalità egoista e falsa.
 Il Viaggio di Arlo ha dalla sua unicamente un motore grafico straordinariamente curato, ove la realizzazione tecnica, ovvero la forma, ha la meglio sui contenuti, vale a dire la sostanza, e se da un lato questo rappresenta l’apice creativo della Pixar, dall’altro ne condanna l’aspetto contenutistico, poiché l’intera avventura è un lento procedere di situazioni viste e riviste, a cui siamo abituati da anni e i personaggi fanno fatica a mettersi in luce, godere di un minimo di carisma o affascinare lo spettatore. A questo, per concludere, va aggiunto un finale scontato, poco sincero e un protagonista a cui va dato il merito di essere il peggiore mai creato dalla Disney/Pixar. Dopo quanto scritto, alla fine della fiera, siamo davanti ad un parziale crollo di una casa di produzione che, da questa caduta, si rialza e mantiene la nostra fiducia solamente grazie al capolavoro Inside Out, che ha preceduto di qualche settimana Il Viaggio di Arlo. Resta comunque un ultimo quesito: “Now, where is the Pixar?”
Il Viaggio di Arlo ha dalla sua unicamente un motore grafico straordinariamente curato, ove la realizzazione tecnica, ovvero la forma, ha la meglio sui contenuti, vale a dire la sostanza, e se da un lato questo rappresenta l’apice creativo della Pixar, dall’altro ne condanna l’aspetto contenutistico, poiché l’intera avventura è un lento procedere di situazioni viste e riviste, a cui siamo abituati da anni e i personaggi fanno fatica a mettersi in luce, godere di un minimo di carisma o affascinare lo spettatore. A questo, per concludere, va aggiunto un finale scontato, poco sincero e un protagonista a cui va dato il merito di essere il peggiore mai creato dalla Disney/Pixar. Dopo quanto scritto, alla fine della fiera, siamo davanti ad un parziale crollo di una casa di produzione che, da questa caduta, si rialza e mantiene la nostra fiducia solamente grazie al capolavoro Inside Out, che ha preceduto di qualche settimana Il Viaggio di Arlo. Resta comunque un ultimo quesito: “Now, where is the Pixar?”















Comments